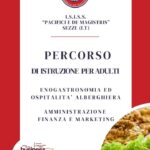Storie di migrazione e sapori ritrovati con il simbolo di un’unione gastronomica nell’Agro Pontino.
La storia dell’Agro Pontino, terra di bonifiche e di nuove comunità provenienti da diverse regioni d’Italia, è anche una storia di incontri e fusioni culturali, che si riflettono in maniera vivida nella sua gastronomia. Tra le tante tradizioni portate dai coloni, una spicca per la sua ingegnosità e per come un semplice strumento sia riuscito a radicarsi profondamente nel tessuto culinario locale: il “bigolaro”.
Ci descrive questo singolare attrezzo il nipote di Maria, una nonna originaria di Piazzola sul Brenta, classe 1930. Come affermava la compianta nonna, che risiedeva a Sermoneta, il “bigolaro” era un elemento fondamentale nelle cucine delle famiglie meno abbienti, soprattutto nel nord-est della penisola. In un’epoca in cui le risorse erano scarse, il “bigolaro” rappresentava una soluzione pratica per realizzare in casa la pasta. La ricetta base per la pasta trafilata con il bigolaro era sorprendentemente semplice: soli 500 grammi di farina, acqua quanto bastava e un pizzico di sale. L’impasto che ne risultava era omogeneo e consistente, perfetto per essere lavorato attraverso le diverse trafile del bigolaro.
Esistono diverse tipologie di questo strumento. Alcuni modelli venivano fissati a un tavolo di legno tramite apposite rientranze, garantendo stabilità durante l’uso. Altri, come quello posseduto da nonna Maria erano ancorati a una sorta di treppiede di legno, sul quale ci si sedeva per mantenerlo fermo mentre si “menava torno”, ovvero si azionava la vite per trafilare l’impasto.
Prima di iniziare, si sceglieva e si inseriva la piastra desiderata, che poteva avere diverse forme per ottenere spaghetti, bigoli e bucatini. Le trafile per le forme cave erano naturalmente aperte su un lato per permettere al ferro di modellare la pasta. L’impasto veniva introdotto a piccole dosi nel tronco centrale, inclinando lo stantuffo per facilitarne l’accesso. Poi, ruotando il manico, si spingeva l’impasto attraverso la filiera. Al termine del processo, con pazienza, si svitava l’intero meccanismo per poter ripetere l’operazione.
I “bigoli” così ottenuti venivano poi messi ad essiccare su canne di bambù appese, le “perteghe” o “perteghele”, per una durata di circa una settimana. La preparazione settimanale garantiva una scorta sufficiente per i giorni a venire. La cottura era semplice, in acqua bollente, proprio come la pasta acquistata oggi.
Con il passare del tempo e il miglioramento delle condizioni economiche dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche le ricette si evolsero. Nonna Maria, ad esempio, iniziò ad arricchire l’impasto base con spezie come la noce moscata, conferendo un sapore più aromatico alla pasta fatta in casa che veniva condito con salse prodotte proprio nel podere.
L’arrivo di queste genti venete nell’Agro Pontino portò con sé non solo la loro forza lavoro e la loro cultura, ma anche le loro tradizioni culinarie e i loro strumenti. Il “bigolaro”, da semplice strumento di necessità, divenne un simbolo di ingegno e di capacità di trasformare ingredienti poveri in un alimento sostanzioso.
Oggi, nell’Agro Pontino, il termine “bigolaro” non è più relegato ai soli immigrati veneti o ai più anziani. La sua praticità e la bontà della pasta fresca fatta in casa hanno fatto sì che questo strumento, un tempo simbolo di un’epoca di ristrettezze, sia diventato parte integrante del patrimonio culinario locale. Nelle cucine delle nonne pontine, proprio come faceva nonna Maria, accanto alle ricette tradizionali della zona, non è raro trovare un “bigolaro”, testimone silenzioso di un incontro fecondo tra culture e sapori, un ponte gustativo tra le terre venete e la fertile pianura laziale. La sua diffusione nell’Agro Pontino è la prova tangibile di come le necessità possano generare tradizioni durature, arricchendo il panorama gastronomico di un territorio con nuove sfumature di gusto e di storia.
 Segui il canale DiarioPontino!
Segui il canale DiarioPontino!
 Resta aggiornato direttamente su WHATSAPP
Resta aggiornato direttamente su WHATSAPP  ISCRIVITI ORA!
ISCRIVITI ORA!